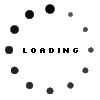Scienza, tecnologia e responsabilità: una riflessione
1 Settembre 2020«La scienza in un certo senso è universale. Non nel senso che tutti gli uomini partecipano alla sua edificazione ma nel senso che tutti gli uomini possono parteciparvi. Essa è indipendente dalla nazionalità, dalla posizione geografica e, sebbene non si possa dire dalla cultura, è certo singolarmente indipendente dalla forma di governo, dalla tradizione più recente, dalla vita affettiva di un popolo. Essa ha a che fare con l’umanitas» (Oppenheimer).
La scienza è una questione comune e Oppeiheimer sostenne la necessità di trovare un senso di responsabilità collettiva e mise in evidenza il bisogno di impostare una politica atomica internazionale. Proprio perché le armi atomiche erano, e sono tuttora, un motivo di preoccupazione per gli uomini di tutto il mondo, egli riteneva necessario, per fronteggiare questo problema, un senso di responsabilità condiviso dall’intera comunità degli uomini di scienza.
Questo prototipo di collaborazione planetaria rappresentava per questo scienziato un cambiamento nelle coscienze, non solo per fronteggiare il pericolo delle armi atomiche ma a salvaguardia di concetti come quelli di “democrazia” e di un mondo unito in cui non ci siano più guerre. Principi per i quali gli individui sono stati pronti a offrire la propria vita spinti dal legame comune che unisce gli uomini con altri uomini di ogni altra parte del mondo.
Per queste argomentazioni la posizione di Oppenheimer, contrario all’imposizione dei segreti militari sulla scienza, fu sospettata e poi accusata di comunismo. Nel suo discorso alla comunità degli scienziati, il 2 novembre 1945, Oppenheimer antepose quindi l’etica alla scienza quando ricordò ai colleghi che non potevano dimenticarsi di essere uomini e di dipendere in senso strettamente morale dai propri simili.
Il valore della scienza deve essere riposto nel mondo degli uomini con cui gli scienziati hanno i loro legami più profondi. Una parte importante nella realizzazione della bomba atomica la ebbe anche Albert Einstein quando indirizzò una lettera, nell’ottobre del 1939, al Presidente degli Stati Uniti d’America, Roosevelt, raccomandando l’appoggio finanziario e l’accelerazione della ricerca atomica.
Successivamente, anch’egli si fece promotore, insieme a Bertrand Russell, della pubblicazione a Londra nel 1955 di un Manifesto per la pace nel quale si informavano le autorità mondiali e il pubblico dei rischi che la corsa agli armamenti portava all’umanità. Il Manifesto fu sottoscritto in breve tempo da migliaia di intellettuali di tutto il mondo sebbene, purtroppo, da una parte gli scienziati informavano la società civile, dall’altra continuavano a operare nei laboratori di morte.
Sulla questione della neutralità dello scienziato rispetto ai valori, Einstein distingueva i due compiti del lavoratore intellettuale: quello di scienziato e quello di cittadino. Come può lo scienziato che per quanto è possibile conserva un’assoluta oggettività nel suo laboratorio, interessarsi, o addirittura occuparsi, dei giudizi di valore? Come possono gli scienziati conciliare il loro operato con tali giudizi che sono, per loro stessa natura, o di carattere molto soggettivo, se riguardano i loro interessi, o di carattere filosofico, se riguardano le norme etiche o morali? Oppenheimer, nel suo impegno per il controllo degli armamenti nucleari, compie in maniera più netta una sintesi fra il ruolo dello scienziato e quello del cittadino, attribuendo in tal modo dei giudizi di valore ai risultati dell’attività scientifica. Egli lo fece, quindi, concretamente, con la scelta di opporsi alla costruzione della bomba a idrogeno, la superbomba, ritardandone così la realizzazione, poi effettuata da Edward Teller, e rifiutandosi di trasferirsi a Los Alamos per lavorare su di essa. Quindi è fondamentale la differenza fra informare soltanto dei rischi connessi ai risultati della ricerca scientifica, in particolare in relazione agli armamenti nucleari, e attribuire dei valori alla scienza di cui si fa pratica.
La posizione di Oppenheimer è forse la più avanzata rispetto a quella del manifesto di Einstein e Russel, ma di fatto rimase sempre più isolata. Non si sa da quando l’umanità ha smesso di fidarsi ciecamente della scienza. Lo faceva certamente in pieno Ottocento, nell’epoca chiamata “positivismo”, in cui si credeva che tutti i problemi del mondo sarebbero stati risolti dal progresso scientifico e tecnologico e che tutti i misteri sarebbero stati ricondotti al lume della ragione. Questo rapporto di cieca fiducia venne meno l’8 agosto 1945, quando Hiroshima fu rasa al suolo dal sole artificiale realizzato dagli scienziati atomici. La paura della scienza è un argomento di grande attualità. Moltissimi, soprattutto tra i più giovani, non si fidano della scienza, intesa quest’ultima nel suo senso più ampio. La medicina, per esempio: si dimentica che la ricerca ci ha permesso di estendere la speranza di vita di molti anni nell’ultimo secolo, sconfiggendo tantissime malattie, e si sottolinea solo l’incapacità della scienza “ufficiale” (come se ne esistesse una “non-ufficiale”) di non riuscire a sconfiggere il cancro. Si guarda con sospetto alla biotecnologia, e naturalmente al nucleare. Gli scienziati difficilmente riescono a comprendere immediatamente le eventuali ricadute negative delle loro ricerche. L’esempio dell’energia nucleare non è assolutamente campato per aria.
Chi ha letto le memorie degli scienziati atomici degli anni di Los Alamos Oppenheimer, Szilard, Teller scoprirà che erano perfettamente a conoscenza della possibilità che le loro ricerche portassero alla realizzazione della più spaventosa arma mai concepita dall’umanità. Non ci volle molto perché superassero i loro dubbi e decidessero addirittura di convincere il governo americano a sovvenzionare con miliardi di dollari quello che divenne noto come Progetto Manhattan. E non è vero che lo fecero solo perché temevano che Hitler arrivasse alla bomba prima di loro. Semplicemente, da buoni scienziati, volevano veder realizzata la loro idea. E questa verità diventerà ancora più evidente negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale. Dopo i tragici “esempi dimostrativi” di Hiroshima e Nagasaki, gli scienziati di Los Alamos sapevano perfettamente cosa potevano realizzare le loro bombe.
Eppure, dopo aver nuovamente messo da parte i loro dubbi, portarono avanti il progetto di Edward Teller per realizzare un’arma ancora più potente, la bomba all’idrogeno, o bomba H. E la sperimentarono, senza nemmeno sapere esattamente quali sarebbero stati gli effetti del test. È noto infatti che alcuni di loro temevano che l’esplosione fosse addirittura capace di incendiare l’atmosfera terrestre e provocare una vera e propria fine del mondo. Allora forse, suggeriva Sciascia nel suo magistrale lavoro La scomparsa di Ettore Majorana, il grande scienziato italiano decise di scomparire o di morire, il che fa lo stesso per evitare di compromettersi con il più terribile e spaventoso progetto della storia della scienza. Emilio Segré, ricorda Majorana, chiamò “provvidenziale” la cecità degli scienziati di via Panisperna (tra cui c’era Fermi, poi emigrato in America, e lo stesso Majorana), che non seppero riconoscere la fissione nucleare quando la realizzarono a Roma per la prima volta nella metà degli anni ’30. Ma per i giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, non fu certo provvidenziale la mancata “cecità” dei fisici americani.
Le parole più sagge sono quelle di Margherita Hack: «Certo è anche vero che la ricerca va per tentativi e di conseguenza non ci si può subito rendere conto dell’eventuale portata negativa; in tal caso bisognerebbe saper rinunciare». E quanti scienziati, oggi, rinuncerebbero a firmare una loro scoperta da Nobel, pur consapevoli dell’eventuale portata negativa di cui parla Hack? Pochi. Forse nessuno. Soprattutto in un’epoca in cui, rispetto a ieri, la ricerca è fortemente guidata dal mercato, considerando anche che lo Stato non è più abbastanza capace di finanziare la ricerca pubblica. Gli scienziati scoprono nuovi farmaci retrovirali, o nuovi farmaci antitumorali, ma sono le aziende farmaceutiche a brevettarli, a venderli e a imporre i prezzi; prezzi che spesso impediscono ai paesi in via di sviluppo i più bisognosi ad accedere a questo tipo di cure. Un dilemma etico che pone un’ombra pesantissima sulla scienza. Cosa dovrebbe fare oggi uno scienziato, di fronte a questo dilemma? Continuare a lavorare autoassolvendosi in nome del vecchio principio della neutralità della scienza, o abbandonare tutto, compreso un lauto stipendio, con poche prospettive di trovare una nuova nicchia occupazionale, per rispettare l’imperativo morale di Hans Jonas: «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra»? Un problema davvero, una volta tanto, da “maturità”.